Con il mese di settembre la nostra uscita mensile quale “rubrica letteraria”, solitamente collocata nei fine mese, si arricchirà.
Infatti, non saranno più soltanto recensioni di libri o di riviste, ma offriremo anche interventi, brani e spunti tratti da pezzi giornalistici, da blog o riviste digitali e da social i più diversi, aventi rilevanza e interesse per gli argomenti trattati o per le particolari visioni proposte.
Buona lettura!
L'ASINO MANCINO
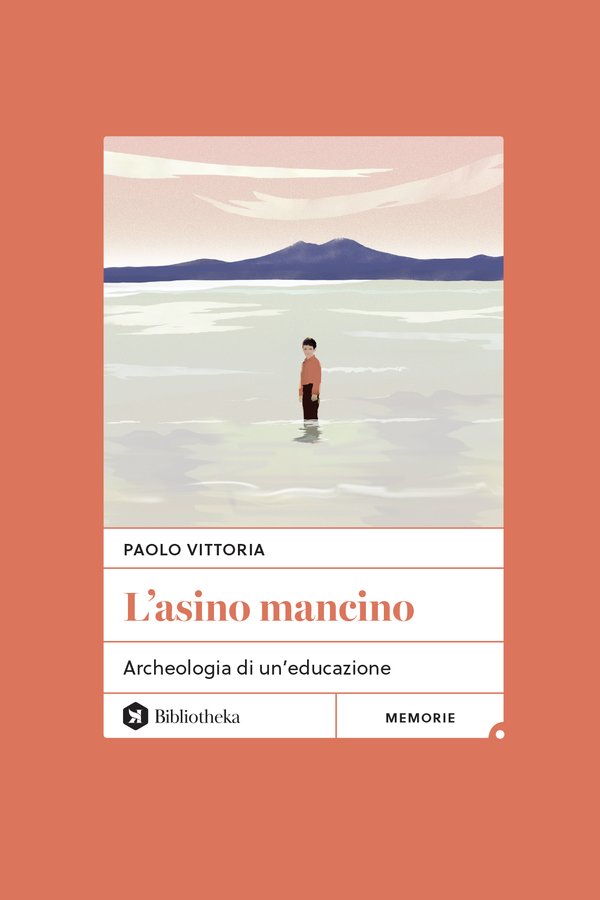
Spunti dall’omonimo libro di Paolo Vittoria, a cura di Gianni Faccin per Librarsi Liberi
Come riportato in quarta di copertina, questo è un libro vivamente sconsigliato a chi non la fantasia per immaginare che il ragazzo dell’ultimo banco possa un giorno diventare professore. Come è capitato all’autore del libro, da “asino” alle elementari a docente universitario. Infatti, Paolo Vittoria è professore di pedagogia generale e sociale all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha insegnato a lungo in Brasile all’Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Condirettore di Educazione Aperta, Rivista di Pedagogia Critica, collabora con il quotidiano Il Manifesto. Ha pubblicato il libro “L’asino mancino. Archeologia di un’educazione” ed altri lavori.
Confesso che ho trovato in questo libro, incontrato per caso, molti punti in comune sia nella narrazione, sia nel percorso dell’autore. Anche la sua affinità con Paulo Freire mi ha molto stimolato.
Ecco alcuni spunti scelti che si riferiscono a vari passaggi del libro.
I giovani e la scuola
Vivendo al fianco di studentesse e studenti, sento che si respira un’aria molto pesante per quanto riguarda l’attesa, l’aspettativa, l’ansia. Un modello didattico che induce all’individualismo e alla competizione – il tanto decantato sistema delle competenze – gioca un ruolo decisivo in questo malessere.
Del resto, se continuiamo ad utilizzare con naturalezza un vocabolario dove invitiamo ad accumulare, spendere, certificare competenze, crediti e debiti, cosa potremmo aspettarci? Così, attraverso il libro L’asino mancino. Archeologia di un’educazione, ho deciso di prendermi gioco dell’ideologia del merito, dell’eccellenza, raccontando da “prof” le mie fragilità, insicurezze di studente, e non solo.
L’inizio è sempre in salita
Le difficoltà a scuola sono iniziate molto presto, già ai primissimi passi in cui non riuscivo a scrivere. Oggi comprendo che non sapevo scrivere perché ero mancino e, per mera superstizione, sono stato “istruito” come tanti altri, all’uso della mano destra.
Quindi il mio esordio in una scuola che non segue i processi cognitivi del bambino, ma impone delle assurde forzature, è stato certamente faticoso, come la salita per un asino. Fabrizio De André la descriverebbe come una creuza, una mulattiera.
Eccellenza e merito
Non me la sono vista meglio negli anni a seguire dove cercavo un cammino di senso tra bocciature e rimandi. Il cammino l’ho trovato, anzi lo cerco ancora, nell’insegnamento e nella scrittura dove prendo spunto da alcune vicende personali, anche goffe, da incontri, viaggi ma anche bocciature (non solo didattiche, ma esistenziali) come opportunità per parlare di scuola a partire dall’ultimo banco, dove generalmente sceglievo di rifugiarmi. Perché sono convinto che l’eccellenza e il merito non siano il punto di vista più giusto per capire l’educazione, che un sorriso valga molto di più di una lode o della certificazione di una competenza. Anche perché l’apprendimento non andrebbe certificato, ma avrebbe solo bisogno di trovare gli spazi e i tempi giusti. Ed allora… via libera a tutti gli asini, perché siano liberi di viaggiare.
La teoria del circolo
Quindi, via la cattedra, banchi e sedie in circolo, quando è possibile visto che – purtroppo – la tendenza è quella delle sedie fisse. In ogni caso stare in circolo, al di là della disposizione geografica, significa vivere di relazione, stare nella relazione.
Se l’educazione si costituisce come luogo di dibattito e, confronto, domande e inquietudini, si rende possibile l’espressione individuale e collettiva che già inizia dal rispetto del chiamare gli studenti per nome e questo vuol dire lavorare affinché scuola e università siano spazi autenticamente democratici. D’altra parte, un Paese non è realmente democratico se non lo sono le sue istituzioni educative.
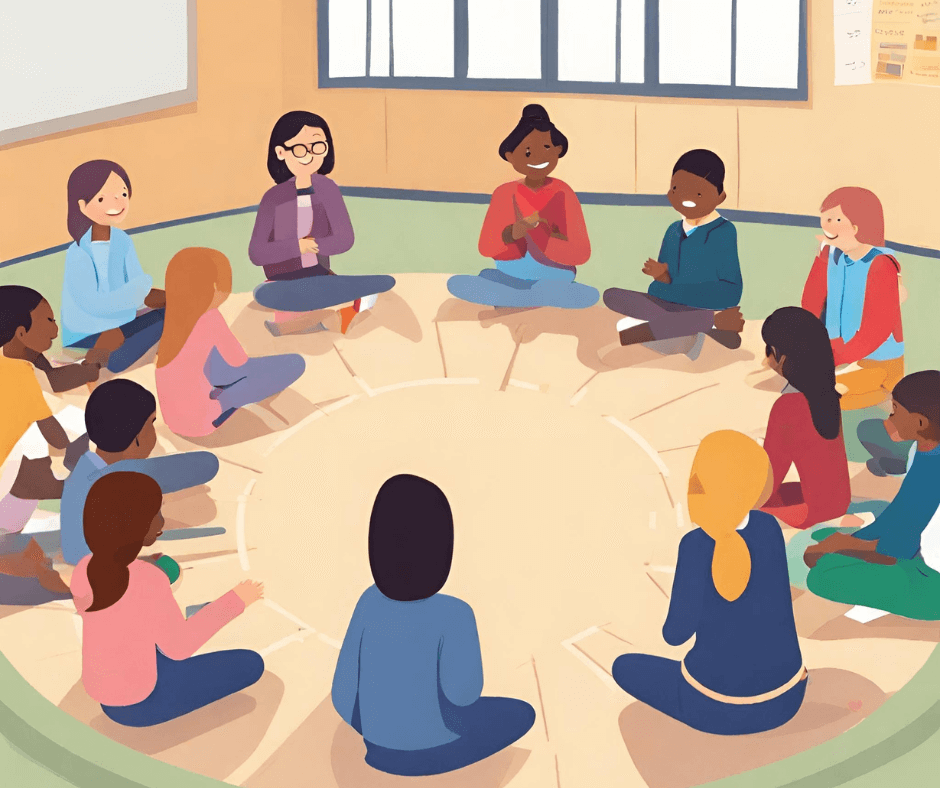
Saggezza
Noi invece dobbiamo lavorare sulla saggezza che dà vita alla conoscenza. Mentre le conoscenze possono dividere tra chi ne ha di più e chi ne ha di meno, la saggezza appartiene a tutti: dal professionista a chi non sa parlare bene ma parla con saggezza; da chi parla poco ma agisce con saggezza alla saggezza dei bambini a quella delle persone anziane; dalla saggezza del mondo contadino alla saggezza intrinseca ai proverbi; anche la saggezza di un animale, di un asino, o di un insetto, una formica, una stella.
L’ascolto di idee diverse
E non c’è insegnamento senza apprendimento. Un elemento però è indispensabile: ascoltare e far vivere le diverse idee. Impossibile che emerga saggezza senza che si possa esprimere un’opinione. Una scuola senza saggezza non è una scuola, ma una fabbrica di nozioni prodotte come in catena di montaggio, pronte per essere impacchettate, immesse e svendute al magnifico mercato delle competenze.
Nota: spunti tratti dal libro citato, testo tra i titoli consigliati della nostra libroteca.


Per iscriverti alla nostra newsletter, manda una mail a info@gsmsangiorgio.org, oppure clicca QUI.
Con affetto



0 commenti